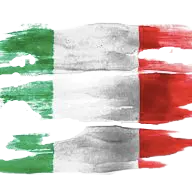Legge n. 74/2025: nuove norme sulla cittadinanza italiana
Principali novità introdotte dalla riforma del 2025
La Legge 23 maggio 2025, n. 74 ha portato una riforma significativa della disciplina sulla cittadinanza italiana, convertendo con modifiche il D.L. 36/2025. Le principali novità riguardano soprattutto i discendenti di italiani all’estero e i requisiti di acquisizione della cittadinanza. In sintesi, la riforma ha introdotto:
- Limiti allo ius sanguinis: stop all’automatismo della cittadinanza per discendenza illimitata; chi nasce all’estero da avi italiani non è più automaticamente cittadino italiano senza ulteriori condizioni. In pratica, la cittadinanza per discendenza è garantita automaticamente solo fino ai nipoti di italiani nati in Italia.
- Nuovi requisiti di residenza e legame con l’Italia: per acquisire o riacquisire la cittadinanza ora è necessario dimostrare un “legame effettivo” col Paese (es. anni di residenza in Italia). L’obiettivo dichiarato è assicurare che solo chi abbia un vincolo reale, non solo genealogico, entri a far parte della comunità dei cittadini.
- Procedure agevolate per oriundi e rimpatri: introdotte facilitazioni per favorire il rientro dei discendenti di italiani (ingresso per lavoro fuori quota e naturalizzazione più rapida).
- Riapertura del riacquisto per ex cittadini: prevista una finestra temporale per chi aveva perso la cittadinanza secondo vecchie norme, consentendo di riottenerla su domanda.
- Restrizioni probatorie nei contenziosi: nei procedimenti per riconoscimento di cittadinanza o status di apolide non sono più ammessi giuramento e testimonianze, e l’onere della prova ricade sul richiedente.
Nuove modalità di acquisizione della cittadinanza
Le modifiche intervengono sulle diverse modalità di acquisto della cittadinanza – dallo ius sanguinis, allo ius soli temperato, fino alla naturalizzazione per residenza – introducendo criteri più stringenti ma anche alcune agevolazioni.
Modifiche allo ius sanguinis (diritto di sangue)
La riforma mantiene il principio dello ius sanguinis, ma limita la trasmissione automatica ai soli figli e nipoti di cittadini italiani nati in Italia. In particolare, non viene più riconosciuta automaticamente la cittadinanza ai discendenti oltre la seconda generazione se nati all’estero e già in possesso di un’altra cittadinanza.
Per continuare a ottenere la cittadinanza per discendenza, il richiedente nato all’estero deve rientrare in precise condizioni eccezionali previste dalla legge. Ad esempio, è necessario che:
- Ascendenza diretta entro il secondo grado: almeno un genitore o un nonno dell’interessato sia nato in Italia (e possedesse solo la cittadinanza italiana). Ciò significa che se l’avo italiano aveva doppia cittadinanza, la trasmissione automatica si interrompe a quella generazione.
- Residenza in Italia di un genitore: uno dei genitori del richiedente abbia risieduto legalmente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della nascita (o adozione) del figlio.
- Procedura già avviata prima della riforma: la domanda di riconoscimento (amministrativa o giudiziaria) fosse stata presentata entro il 27 marzo 2025. In tal caso, la pratica viene ancora esaminata secondo le regole precedenti, senza applicare le nuove restrizioni.
Chi non rientra in nessuno di questi casi non viene più considerato cittadino italiano dalla nascita, pur essendo di origine italiana. Dovrà eventualmente avviare un nuovo iter per richiedere la cittadinanza dimostrando un legame attivo con l’Italia (ad esempio attraverso anni di residenza effettiva nel Paese). Importante sottolineare che queste limitazioni valgono anche per i nati prima dell’entrata in vigore della legge, ma non producono apolidia: se la persona non aveva altra cittadinanza e avrebbe altrimenti perso quella italiana, la restrizione non si applica. Inoltre, restano validi tutti i riconoscimenti già ottenuti: chi era già cittadino italiano per riconoscimento iure sanguinis conserva la cittadinanza.
Acquisto per i minori (ius soli temperato e beneficio di legge)
La legge introduce anche nuove modalità di acquisto per alcuni minori, sia in Italia che all’estero, anche se non si tratta di un vero ius soli automatico. Le novità principali sono:
- Figli di italiani nati in Italia: un bambino nato in Italia da genitori italiani è cittadino automaticamente (ius sanguinis, com’era già). La novità riguarda i figli di italiani nati all’estero: d’ora in poi acquisiranno la cittadinanza automaticamente solo se nascono sul territorio italiano, oppure se prima della loro nascita uno dei genitori (già cittadino) ha residuto almeno 2 anni in Italia. Questa norma mira a garantire che anche per la seconda generazione all’estero vi sia un qualche legame territoriale diretto con l’Italia.
- Minori stranieri o apolidi figli di italiani: è istituita una nuova forma di acquisizione per beneficio di legge rivolta ai minori che sono figli di cittadini italiani per nascita ma che, per varie ragioni, non hanno la cittadinanza (ad esempio, perché nati all’estero e non aventi automaticamente diritto secondo le nuove regole). In questi casi, i genitori o il tutore possono presentare una dichiarazione di volontà per far ottenere al minore la cittadinanza, a condizione che il minore risieda legalmente e continuativamente in Italia per almeno 2 anni successivi alla dichiarazione. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata entro un anno dalla nascita (o dal riconoscimento/adozione) se uno dei genitori è cittadino italiano. Questa previsione facilita l’acquisizione della cittadinanza per minori che, pur avendo genitori italiani, si trovino formalmente stranieri o apolidi.
- Minori conviventi con genitore che acquista la cittadinanza: la legge ha modificato l’art. 14 della legge n. 91/1992 riguardante i figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza. In precedenza, tali figli diventavano automaticamente italiani se convivevano col genitore al momento dell’acquisto/riacquisto, con facoltà di rinuncia al raggiungimento della maggiore età. Ora si stabilisce che ciò avviene solo se il minore risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni continuativi alla data in cui il genitore acquista/riacquista la cittadinanza (o, se il minore ha meno di 2 anni, che abbia risieduto in Italia fin dalla nascita). Questa clausola aggiuntiva assicura che anche in caso di naturalizzazione o riacquisto del genitore, il minore entri nella cittadinanza italiana solo se inserito da tempo nel contesto nazionale.
- Figli minori di neo-cittadini iure sanguinis: come misura transitoria, la legge consente ai minorenni figli di persone diventate cittadini italiani per discendenza (iure sanguinis) di ottenere a loro volta la cittadinanza per “acquisto”, anche se hanno più di un anno di età (superando il precedente limite anagrafico per la trasmissione). Per usufruire di questa possibilità, i genitori devono iscrivere il figlio come cittadino italiano entro il 31 maggio 2026. In pratica, le famiglie di italiani all’estero che sono riusciti a farsi riconoscere cittadini con le vecchie regole (entro marzo 2025) hanno un tempo limitato per “allacciare” anche i figli minorenni al nuovo status del genitore.
Va evidenziato che non è stata introdotta una forma di ius soli pieno per i figli di stranieri nati in Italia (la riforma non prevede la cittadinanza automatica per nascita sul territorio se i genitori sono stranieri). Permane però la regola già esistente: il minore straniero nato in Italia può richiedere la cittadinanza al compimento dei 18 anni, se ha risieduto legalmente e senza interruzioni fino a quella data (art. 4, co.2 L.91/1992). La novità è l’introduzione di un meccanismo semplificato per chi è nato in Italia da genitori stranieri e vi risiede da alcuni anni: costoro, se già maggiorenni, possono ora ottenere la cittadinanza mediante naturalizzazione con soli 3 anni di residenza legale (vedi oltre), invece dei 10 anni normalmente richiesti.
Agevolazioni per naturalizzazione e immigrazione di ritorno
Accanto alle restrizioni, la legge 74/2025 prevede anche alcune agevolazioni mirate a rinsaldare il legame con gli oriundi di origine italiana e a favorire l’“immigrazione di ritorno” delle comunità italiane all’estero. In particolare:
- Naturalizzazione accelerata per discendenti di italiani: è stato modificato l’art. 9 della legge 91/1992 riducendo i tempi di residenza necessari per la concessione della cittadinanza agli stranieri di origine italiana. Ora può chiedere la cittadinanza per residenza lo straniero il cui padre o madre (o un ascendente in linea retta di 2º grado) sia o sia stato cittadino italiano per nascita, dopo 2 anni di residenza legale continuativa in Italia. Prima della riforma erano richiesti 3 anni in tali casi; la riduzione facilita dunque i nipoti di italiani che decidono di stabilirsi in Italia. Inoltre, è confermato che lo straniero nato in Italia (da genitori non italiani) può ottenere la cittadinanza dopo 3 anni di residenza legale. Questa nuova lettera a-bis dell’art. 9 avvantaggia la cosiddetta “seconda generazione” già adulta: chi è nato sul suolo italiano ma non è cittadino per altre vie, può naturalizzarsi con soli 3 anni di permanenza (invece dei 10 normalmente previsti per i non originari).
- Ingresso facilitato per lavoro per oriundi: per gli stranieri residenti all’estero che sono discendenti diretti di cittadini italiani e hanno la cittadinanza di Paesi di storica emigrazione italiana (es. Argentina, Brasile, USA, ecc.), viene introdotta una corsia preferenziale per venire a vivere e lavorare in Italia. Tali persone potranno ottenere un visto e permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza sottostare alle quote annuali del decreto flussi. Sarà un decreto interministeriale a definire la lista dei Paesi beneficiari, ma l’idea è di incentivare i giovani di origine italiana nel mondo a trasferirsi in Italia, contribuendo al tessuto sociale ed economico nazionale.
- Riacquisto della cittadinanza per ex italiani: la legge riapre dopo molti anni la possibilità, per chi era italiano e ha perso la cittadinanza, di riottenerla con una semplice dichiarazione. In base alle modifiche all’art. 13 della legge 91/1992, chiunque abbia perso la cittadinanza ai sensi della legge del 1912 (ad esempio per aver acquisito una cittadinanza straniera quando vigeva il divieto di doppio passaporto) può ora riacquistarla presentando una dichiarazione formale tra il 1º luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Questa opportunità è riservata agli ex cittadini nati in Italia o che vi abbiano risieduto per almeno 2 anni continuativi, e risponde all’esigenza di sanare situazioni di perdita automatica dovute a normative ormai superate. Il riacquisto così previsto è volontario e non opera in modo automatico: l’interessato deve attivarsi presentando la richiesta presso le autorità competenti (consolato o Comune in Italia). Si tratta di una misura accolta con favore da molti ex-italiani (ad esempio donne che avevano perso la cittadinanza sposando stranieri prima del 1975, o emigrati che l’avevano dovuta abbandonare in passato), che ora vedono riconosciuta una nuova chance di tornare formalmente cittadini italiani.
Impatto sui cittadini stranieri residenti in Italia (minori e seconde generazioni)
La riforma del 2025 ha ripercussioni diverse per gli stranieri che vivono in Italia, in particolare per i minori e i giovani di seconda generazione nati o cresciuti nel Paese.
Da un lato, vi sono alcuni miglioramenti sul fronte dell’inclusione: ad esempio, i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri possono aspirare alla cittadinanza in tempi più brevi rispetto al passato. Se non riescono (o non vogliono) sfruttare l’acquisizione al 18º anno con la procedura speciale, potranno comunque presentare domanda di naturalizzazione dopo 3 anni di residenza legale (grazie al nuovo art. 9, co.1 lett. a-bis). In pratica, un giovane di origine straniera ma nato sul suolo italiano, che magari abbia lasciato il Paese per un periodo o non abbia fatto in tempo a formalizzare la cittadinanza entro i 19 anni, adesso ha un percorso più agevole per diventare cittadino senza attendere i lunghi 10 anni previsti per la maggior parte degli immigrati. Questa modifica rappresenta un passo avanti verso il riconoscimento delle seconde generazioni, sebbene in forma di ius culturae attenuato (basato sulla permanenza effettiva in Italia).
D’altro canto, tuttavia, la legge non introduce un vero diritto alla cittadinanza per i minori stranieri nati o cresciuti in Italia. Non è stato adottato lo “ius soli” puro né il cosiddetto “ius scholae” (cittadinanza dopo un ciclo scolastico): i bambini nati da genitori immigrati restano stranieri fino alla maggiore età, salvo casi particolari. Organizzazioni e associazioni delle seconde generazioni hanno espresso delusione perché la riforma si è focalizzata soprattutto sugli italo-discendenti all’estero, lasciando invariata la condizione di chi è nato e socializzato in Italia da genitori stranieri. In altre parole, per la maggior parte dei giovani stranieri cresciuti in Italia nulla cambia nel breve periodo: continuano ad applicarsi le norme vigenti (richiesta al compimento dei 18 anni, oppure naturalizzazione per residenza decennale se arrivati più tardi).
Un impatto rilevante è invece riscontrabile per i minori stranieri con genitori che acquisiscono la cittadinanza. La nuova richiesta di 2 anni di residenza in Italia del minore per poter “seguire” il genitore nella cittadinanza introduce un elemento di restrizione. Ad esempio, una famiglia di origine straniera che ottenga la cittadinanza italiana (per residenza o per riacquisto) dovrà assicurarsi che i figli minorenni abbiano già un sufficiente radicamento in Italia, altrimenti questi non diventeranno automaticamente cittadini insieme al genitore. Questo potrebbe verificarsi nel caso di italiani residenti all’estero che riacquistano la cittadinanza: se i figli minorenni non vivono ancora stabilmente in Italia, non acquisiranno la cittadinanza contestualmente al genitore, come invece accadeva in passato. Ciò implica che quei minori dovranno eventualmente seguire un percorso a parte (ad esempio trasferirsi e maturare gli anni di residenza richiesti, o attendere la maggiore età) per ottenere la cittadinanza. Alcuni esperti hanno criticato questa scelta, sostenendo che penalizza ingiustamente i minori e potrebbe creare disparità all’interno dello stesso nucleo familiare (genitori cittadini, figli minorenni temporaneamente esclusi).
In generale, l’impatto della legge sui cittadini stranieri residenti in Italia è quindi contrastante: se da un lato si registra un’apertura (seppur limitata) verso la seconda generazione già integrata, dall’altro lato si evidenziano mancate riforme attese (come lo ius soli per i nuovi nati) e nuovi ostacoli per alcuni minori nel conseguire la cittadinanza. Il dibattito pubblico italiano in materia di cittadinanza, infatti, resta diviso: le forze politiche di governo nel 2025 hanno privilegiato l’idea del “legame effettivo” e della cittadinanza come punto di arrivo di un percorso di integrazione, piuttosto che come diritto acquisito per nascita sul territorio. Di conseguenza, molte famiglie straniere dovranno continuare a confrontarsi con iter burocratici complessi e tempi lunghi affinché i figli nati o cresciuti in Italia diventino pienamente cittadini italiani.
Elementi controversi e dibattiti sulla nuova legge
La Legge n. 74/2025 ha suscitato ampie discussioni e polemiche, sia in Italia sia soprattutto all’estero, nelle comunità di oriundi italiani. Tra gli elementi più controversi vi è sicuramente la stretta sul ius sanguinis: l’aver posto un limite generazionale ai riconoscimenti della cittadinanza per discendenza è stato accolto con favore da alcuni (che vi vedevano una necessaria modernizzazione), ma con forte contrarietà da altri. In particolare, molte associazioni di italo-discendenti (specie in Sud America) hanno criticato la riforma come una “grande perdita” del diritto alla cittadinanza italiana per milioni di persone di origine italiana nel mondo. La riforma è stata accompagnata da un acceso dibattito internazionale: giuristi e rappresentanti degli italiani all’estero hanno addirittura ipotizzato profili di incostituzionalità su diversi fronti, sostenendo che la legge discrimina in base alla nascita e rompe un legame storico che l’Italia aveva sempre riconosciuto ai suoi emigrati e discendenti.
Un punto dibattuto è il carattere in parte retroattivo delle nuove norme. Pur non revocando formalmente la cittadinanza a nessuno che l’abbia già ottenuta, la legge esclude dal riconoscimento automatico persone già nate da molti anni (anche decenni fa) che fino al giorno prima della riforma avevano il diritto di essere riconosciute italiane iure sanguinis. Dal 28 marzo 2025, quei soggetti – se non rientrano nelle eccezioni – vengono considerati come se “non avessero mai acquisito” la cittadinanza italiana. Di fatto, per alcuni si tratta di una perdita retroattiva dello status civitatis, sebbene tecnicamente la cittadinanza non fosse ancora stata formalizzata. Questo approccio ha sollevato perplessità etiche e giuridiche: si colpiscono individui che non hanno colpa se i loro avi emigrati hanno trasmesso loro anche un’altra cittadinanza; inoltre, la norma distingue tra discendenti con avi esclusivamente italiani e discendenti con avi naturalizzati altrove, introducendo una sorta di “discriminazione della doppia cittadinanza” (vengono penalizzate le famiglie che in passato hanno acquisito una seconda cittadinanza). Tali distinzioni sono inedite nell’ordinamento italiano e paiono contraddire la tradizionale apertura al dual citizenship: dal 1992 l’Italia consente la doppia cittadinanza, ma con questa legge sembra punire chi discende da italiani che hanno avuto un’altra cittadinanza.
Altra questione controversa riguarda la costituzionalità di alcune parti della riforma. Diversi costituzionalisti hanno osservato che la legge potrebbe violare il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e il rispetto delle condizioni personali dei cittadini. La Corte costituzionale già in passato aveva affermato che la condizione di essere nati all’estero da famiglia italiana non può essere base di discriminazioni tra cittadini. Trasformare d’ufficio gli “oriundi” italiani in semplici stranieri, richiedendo requisiti aggiuntivi per riconoscerli, è stato definito da alcuni una fictio iuris potenzialmente irragionevole e inusitata. Inoltre, il fatto di imporre una restrizione collettiva e indistinta a un ampio gruppo di persone – senza valutazione individuale – ha fatto sorgere dubbi anche rispetto al diritto dell’Unione Europea. In effetti, i cittadini italiani sono automaticamente cittadini UE, con libertà di circolazione e altri diritti: norme che causano la perdita (o mancata acquisizione) della cittadinanza in massa e in modo retroattivo potrebbero confliggere con i principi di proporzionalità e tutela effettiva sanciti dai Trattati UE. Ad esempio, la Corte di Giustizia UE ha in passato censurato leggi nazionali che privavano persone della cittadinanza (e quindi dello status di cittadino europeo) senza un esame caso per caso delle conseguenze.
Sul piano politico interno, la legge ha visto schieramenti contrapposti. Da un lato, il governo dell’epoca (di centro-destra) e chi temeva abusi dello ius sanguinis hanno rivendicato la necessità di porre ordine: i consolati italiani nel mondo erano sommersi da centinaia di migliaia di richieste di riconoscimento, con attese pluriennali; c’era il timore di concedere passaporti UE a persone senza alcun legame concreto con l’Italia. Dall’altro lato, forze di opposizione e rappresentanti degli italiani all’estero hanno denunciato la riforma come punitiva verso la diaspora italiana e poco coraggiosa sul fronte dell’inclusione degli immigrati in Italia. Si è notato come, paradossalmente, una riforma della cittadinanza sia stata usata non per ampliare i diritti civili ma per restringerli, andando in controtendenza rispetto ad altri Paesi occidentali che negli anni hanno introdotto elementi di ius soli. Anche la scelta dello strumento – un decreto-legge d’urgenza – è stata criticata da alcuni: intervenire per decreto su una materia così identitaria, senza un approfondito dibattito parlamentare, è apparso inusuale e dettato forse più da esigenze politico-amministrative immediate (snellire le pratiche consolari) che da una visione organica di riforma.
La sentenza della Corte Costituzionale del 31 luglio 2025 e la legittimità della legge
A poche settimane dall’entrata in vigore della legge 74/2025, la legittimità costituzionale della nuova normativa è già finita sotto esame. Il 31 luglio 2025 è stata depositata la sentenza n. 142/2025 della Corte Costituzionale (annunciata anche dalla Corte di Cassazione), che – pur senza riferirsi direttamente alla legge nuova – tocca temi cruciali per la riforma sulla cittadinanza. In questa pronuncia, la Corte era chiamata a valutare se fossero incostituzionali le vecchie norme (legge 91/1992) nella parte in cui non prevedevano limiti allo ius sanguinis. In pratica, alcuni giudici di merito avevano sollecitato la Consulta ad integrare per via giurisprudenziale la legge, imponendo un limite generazionale alla trasmissione della cittadinanza per discendenza.
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili queste censure, rifiutandosi di intervenire in modo “manipolativo” sulla legge in vigore. Ciò significa che la Corte ha stabilito che spetta al legislatore, non al giudice costituzionale, decidere se e come limitare lo ius sanguinis. Di conseguenza, non ha imposto alcun tetto generazionale alla legge 91/1992 – un tetto che, nel frattempo, il Parlamento aveva già introdotto tramite la legge 74/2025. Le questioni sollevate sono state respinte sul piano procedurale, lasciando quindi intatta la disciplina decisa dal legislatore. Questa decisione, in apparenza tecnica, ha però anche un risvolto importante: implicitamente la Corte ha riconosciuto che non può creare ex novo restrizioni alla cittadinanza che la legge non prevedeva, confermando così la centralità del Parlamento su scelte di tale portata.
Pur fermandosi a dichiarare l’inammissibilità, la sentenza 142/2025 contiene diverse considerazioni che offrono spunti sulle basi costituzionali della cittadinanza – considerazioni che molti hanno letto in controluce come un giudizio sulla riforma del 2025. La Consulta infatti delinea nella motivazione alcuni principi: da un lato, riconosce che dalla Costituzione si possono ricavare indicatori importanti per definire la cittadinanza, quali la comunanza culturale, linguistica e territoriale; dall’altro lato, sottolinea che l’idea di comunità delineata dalla Costituzione è aperta, pluralista e attenta alla tutela delle minoranze. In altre parole, criteri di legame effettivo con la nazione (lingua, cultura, territorio) sono rilevanti, ma non devono tradursi in chiusure identitarie incompatibili con il carattere inclusivo e non discriminatorio della Repubblica.
Un passaggio chiave della sentenza fa riferimento a “criteri del tutto estranei” alla tradizione costituzionale italiana in materia di cittadinanza. Secondo alcuni osservatori, questa frase sembra calzare a pennello proprio per alcune misure della nuova legge 74/2025. In particolare, la norma che considera “mai acquisita” la cittadinanza dai nati all’estero se l’ascendente non aveva “esclusivamente” la cittadinanza italiana appare un criterio estraneo e potenzialmente in contrasto con i valori costituzionali. Come evidenziato dal giurista Nicola Brutti, tale requisito discrimina chiunque abbia un ascendente con doppia cittadinanza (situazione diffusissima nella diaspora) rispetto a chi discende da avi rimasti solo italiani. Una simile soluzione normativa, aggiunge Brutti, pare contraria alla visione pluralista e di tutela delle minoranze che la Corte stessa richiama.
Inoltre, la Corte Costituzionale richiama esplicitamente nella sentenza il diritto dell’Unione Europea come limite all’azione del legislatore in materia di cittadinanza. Viene citata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che ha sanzionato leggi nazionali le quali determinavano la perdita dello status di cittadino UE senza una valutazione individuale delle conseguenze per la persona. Questo riferimento appare molto pertinente, dal punto di vista dei critici, alle nuove norme del 2025: la riforma infatti comporta una restrizione generalizzata e automatica dei diritti di cittadinanza per un’intera categoria (gli oriundi oltre la seconda generazione), senza eccezioni caso per caso. Una tale meccanica potrebbe risultare sproporzionata e irragionevole rispetto agli obiettivi, entrando in tensione con i principi UE di proporzionalità e con il diritto a una tutela individuale. In parole semplici, se un discendente di italiani perde la possibilità di diventare cittadino nonostante forti legami personali con l’Italia, solo perché privo dei requisiti generali introdotti, ciò potrebbe violare standard europei che richiedono di considerare la situazione individuale prima di negare lo status civitatis.
Le conseguenze pratiche della sentenza n. 142/2025, nell’immediato, sono che la legge 74/2025 resta pienamente in vigore: la Corte non ha annullato nulla, poiché formalmente non giudicava quelle nuove disposizioni. Tuttavia, la motivazione della Corte costituzionale ha lanciato dei segnali che il mondo giuridico ha colto. Il fatto che la Consulta insista su concetti come pluralismo, legame territoriale ragionevole e proporzionalità lascia intendere che eventuali eccessi del legislatore potrebbero non superare un futuro vaglio di costituzionalità. E infatti questo scenario è tutt’altro che teorico: già il Tribunale di Torino ha sollevato una questione di legittimità costituzionale proprio sulla legge 74/2025, che verrà discussa dalla Corte costituzionale nel febbraio 2026. In quella sede, la Consulta entrerà nel merito della nuova normativa. Gli “obiter dicta” della sentenza 142/2025 fanno pensare che la Corte affronterà la riforma con attenzione ai profili critici evidenziati: ad esempio potrebbe scrutinare la legittimità del requisito dell’ascendente con cittadinanza esclusiva, o della preclusione per chi ha più di due generazioni di distanza.
Se la Corte dovesse dichiarare incostituzionale qualche parte della legge 74/2025, le conseguenze potrebbero essere rilevanti. Ad esempio, una pronuncia che elimini il vincolo dell’avo esclusivamente italiano riaprirebbe la porta ai discendenti con avi naturalizzati, ripristinando in parte lo ius sanguinis tradizionale. Oppure, la Corte potrebbe richiedere misure meno automatiche e più individualizzate (ad esempio un meccanismo di valutazione del “legame effettivo” caso per caso anziché una rigida esclusione generazionale). Per ora, comunque, la novità pratica è che tutti i nuovi richiedenti cittadini per discendenza devono rispettare i criteri restrittivi introdotti nel 2025, e chi non li soddisfa dovrà seguire vie alternative (naturalizzazione per residenza in Italia, ecc.). Le famiglie italo-straniere coinvolte e i loro legali stanno monitorando da vicino l’evolversi del contenzioso costituzionale, confidando in un possibile correttivo.
In conclusione, la Legge n. 74/2025 rappresenta una svolta epocale nella legislazione sulla cittadinanza italiana. Ha innovato profondamente un impianto fermo dal 1992, spostando l’ago della bilancia verso il principio del legame effettivo con la nazione. Le nuove modalità di acquisizione privilegiano la territorialità, la cultura e la residenza, limitando l’automatismo del sangue. Ciò ha comportato benefici per alcuni (facilitando il ritorno degli oriundi realmente interessati a vivere in Italia, o accelerando la cittadinanza per chi in Italia c’è già nato) e svantaggi per altri (escludendo tanti discendenti lontani e introducendo nuovi requisiti per i minorenni). Il dibattito è tuttora acceso, e la vicenda è in evoluzione: la parola finale sulla costituzionalità di questa riforma spetterà alla Corte Costituzionale, le cui future decisioni potrebbero confermare o correggere la rotta intrapresa, con importanti conseguenze pratiche per migliaia di aspiranti cittadini italiani in Italia e nel mondo.
Fonti:
- Legge 23 maggio 2025, n. 74 (conversione D.L. 36/2025), G.U. n.118/2025.
- Comunicato stampa CdM n. 121 del 28/03/2025.
- Boccadutri Law Firm – Cittadinanza italiana 2025: novità introdotte dalla Legge 74/2025.
- Adnkronos – Intervista Prof. Brutti sulla sentenza Corte Cost. 142/2025.
- DirittoComparato.it – Analisi profili di incostituzionalità L.74/2025.